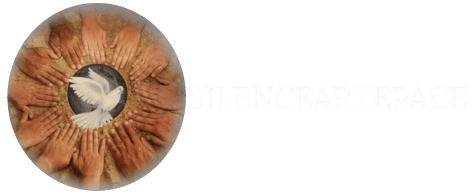L'arte nella storia
La Mandorla Mistica nella storia dellʼarte
Di Pino Blasone, iconologo,storico
(….) lʼutilizzo figurale della “mandorla”, sacra o mistica che sia, non è limitato al Cristianesimo. Si rileva altresì nelle arti di altre religioni, per esempio presso il Buddhismo, là dove abbastanza ovviamente al centro è inclusa la persona del Buddha. La funzione è la stessa: quella di circoscrivere lʼarea del sacro o perfino del divino, distinguendola dalla sfera mondana, compresa a volte una santità più umana, quale pure rappresentata nei dipinti murali citati delle chiese di Santa Sabina e di Sancta Maria Antiqua. Nellʼarte cristiana, a lungo la “mandorla” verrà riservata soprattutto a Gesù e alla Madonna, singolarmente o eccezionalmente insieme sotto lʼaspetto di madre e figlio. Un esempio rinascimentale notevole dellʼultimo tipo è la bella “Madonna col Bambino benedicente entro una mandorla di cherubini”, dipinta intorno al 1500 dal maestro umbro Pietro Vannucci detto il Perugino ovvero nella scuola, che fra gli altri annoverò un giovane Raffaello Sanzio (Pinacoteca di Brera, Milano).
Nellʼambito tuttavia del Rinascimento italiano, in particolare toscano, la raffigurazione più straordinaria sembra essere quella di una terracotta invetriata e policroma, eseguita in rilievo dallo scultore fiorentino Giovanni della Robbia a cavallo tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo, e oggi ospitata in una collezione privata. Infatti, in questo caso abbiamo una corona di angeli, frutti e fiori, tuttʼintorno a una “mandorla” il cui interno è uno spazio lasciato vuoto. Questa volta cioè, esso è davvero o almeno tendenzialmente mistico, nel senso che può quindi prestarsi a essere simbolicamente riempito o interpretato da diverse religioni, in quanto luogo virtuale ove la divinità è in procinto di rivelarsi o, al limite, libera di occultarsi in base alle differenti credenze professate da noi tutti esseri umani.
(….) questʼultima umile ma rara opera possa effettivamente rammentare e ricordare quanto già espresso in versi ispirati dal poeta persiano islamico Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, nel celebre poema allegorico-mistico “Il verbo degli uccelli” redatto nel 1177: «Gli stadi della conoscenza conseguiti dallʼiniziato differiscono. Uno di essi raggiunge la soglia del tempio, mentre un altro rinviene la divinità, la quale vi alloggia. Quando il sole della conoscenza proietta i suoi raggi, ciascuno viene illuminato in ragione delle proprie capacità, trovando nella contemplazione della verità il rango che gli compete. In mezzo alle fiamme, egli vede davanti a sé aprirsi e allungarsi un sentiero, così che per lui la fornace di questo mondo si muta in un giardino di rose. Egli percepisce la mandorla allʼinterno del suo guscio. Vale a dire lʼessenza divina, attraverso il velo dellʼapparenza di ogni cosa».
(….) una riflessione del mistico pure persiano Suhrawardī, vissuto nel dodicesimo secolo, riportata dallʼiranista e islamista francese Henry Corbin nel volume intitolato “Sohrawardi e i platonici di Persia”: «A questo punto-limite interviene lʼincontro con lʼAngelo. Qualora gli adepti non comprendano tali allusioni, essi di fatto non saranno in grado di procedere oltre la menzionata terza montagna. Se invece comprendono, essi sorpasseranno tutto ciò verso la Primavera della Vita. E, quali stille di balsamo, penetreranno dal mondo esteriore delle apparenze naturali in quello interiore delle realtà spirituali, che se ne stanno avvolte da quelle stesse parvenze così come di un mandorlo nel proprio guscio».

LABORATORIO DELLE ARTI
MOSTRE
STORIA DELL’ARTE